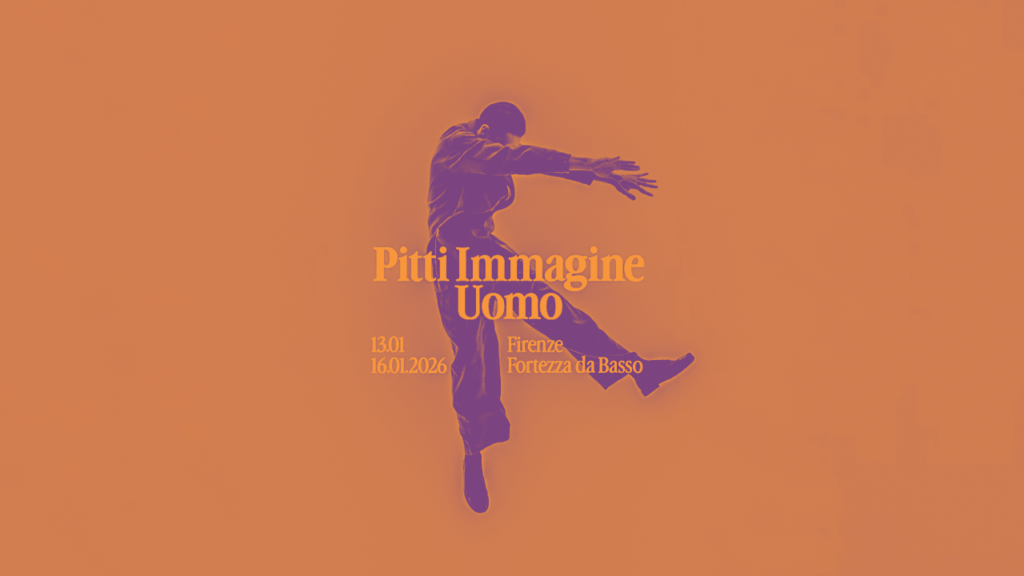2025: Il baratro del lusso tra finanza, creatività e nuove rotte globali
Il mondo della moda continua a soffrire una crisi profonda e prolungata che non accenna a diminuire. I segnali negativi si accumulano giorno dopo giorno, dipingendo un quadro di un settore che fatica a ritrovare la sua stabilità economica e creativa.
Il 2025 si preannuncia come un anno particolarmente complicato, spesso definito dagli esperti come “l’anno nero della moda e del design”, a causa delle molteplici sfide che le maison e i brand devono affrontare.
Questa crisi non è limitata a una singola area geografica o a un segmento specifico della moda, ma coinvolge l’intero ecosistema, dai grandi gruppi del lusso fino ai piccoli laboratori artigianali, minacciando la tradizionale filiera italiana e internazionale. La combinazione di tensioni geopolitiche, cambiamenti nei consumi e una crescente competizione globale rende il contesto estremamente complesso e volatile, ponendo dubbi sul futuro stesso del settore.
Crisi globale e scenari per il 2025
Dopo un 2024 segnato dal rallentamento del mercato cinese, inizialmente indicato come la principale causa della battuta d’arresto nel settore moda, la situazione è rapidamente peggiorata.
Nonostante un’iniziale speranza derivante dal buon andamento del mercato americano, le tensioni politiche legate all’elezione di Donald Trump e la conseguente guerra commerciale con l’imposizione di dazi hanno avuto un impatto molto negativo, soprattutto sui brand del lusso e del design. Questi fattori hanno aggravato la crisi, creando un terreno instabile e sfavorevole agli investimenti.
Oggi la moda si trova a un punto di svolta: la finanza e la creatività, due pilastri fondamentali per l’industria, sembrano viaggiare su binari paralleli destinati a non incontrarsi se non per un cambio di rotta radicale.
In questo contesto, le prossime fashion week assumono un’importanza cruciale, ma i segnali arrivano contrastanti, con un ricambio vertiginoso di direttori creativi e un clima di incertezza che si riflette sia nelle passerelle che nei bilanci.
Debutti attesi e turnover dei direttori creativi
Il settore creativo è al centro di un vero e proprio terremoto, con numerosi debutti e cambi di direzione che stanno trasformando radicalmente il volto della moda internazionale.
Il fenomeno del “turnover” nelle posizioni chiave sta diventando una costante, quasi una risposta alla pressione della finanza che tende a governare i brand più che l’estro creativo. Questo ha portato a un panorama in cui la scelta dei direttori artistici sembra guidata più da logiche economiche che da una visione stilistica a lungo termine.
Nei prossimi mesi assisteremo a un vero e proprio tsunami di debutti, con nomi di rilievo che si preparano a calcare le passerelle:
Milano Fashion Week settembre 2025: Bottega Veneta – Louise Trotter; Gucci – Demna; Versace – Dario Vitale; Jean Paul Gaultier – Duran; Loewe – Jack McCollough e Lazaro Hernandez; Jil Sander – Simone Bellotti
giugno 2025 – Paris Fashion Week: Dior – Jonathan Anderson
Pluglio 2025 – Paris Fashion Week: Maison Margiela – Glenn Martens; Celine – Michael Rider
settembre-ottobre 2025 – Paris Fashion Week: Chanel – Matthieu Blazy; Mugler – Miguel Castro Freitas
Risultati trimestrali negativi e crisi del lavoro
L’aspetto economico conferma la gravità della crisi con risultati trimestrali sempre più deludenti. Le perdite non si limitano ai bilanci ma si riflettono in modo drammatico sul tessuto sociale e occupazionale del settore. Gli artigiani, figure chiave nella tradizione della moda italiana e internazionale, sono i primi a subire le conseguenze di questa fase critica.
Molte aziende hanno già annunciato tagli al personale e chiusure di stabilimenti, fenomeni che rischiano di cancellare competenze storiche difficili da recuperare. I licenziamenti e la precarietà del lavoro mettono in crisi non solo le famiglie, ma l’intero sistema produttivo. Le misure governative e i contratti di solidarietà offrono una boccata d’ossigeno temporanea, ma non bastano a risolvere i problemi strutturali, rendendo urgente un ripensamento del modello produttivo e una nuova politica industriale che tenga conto della tutela del capitale umano.
Bally chiude il sito produttivo in Toscana
Una delle ultime notizie che più colpisce riguarda la chiusura della storica fabbrica Bally di Lastra a Signa, vicino Firenze. Dopo mesi di trattative sindacali infruttuose, 28 lavoratori sono stati licenziati in seguito alla decisione aziendale di chiudere il sito produttivo. Questo stabilimento, un tempo cuore pulsante della manifattura toscana per il settore lusso, aveva già subito una riduzione drastica del personale da 55 a 28 dipendenti.
Il cambio ai vertici aziendali, con l’ingresso del nuovo CEO Ennio Fontana e l’uscita di Simone Bellotti – ex direttore creativo ora approdato a Jil Sander – non è bastato a invertire la rotta.
La chiusura di Bally rappresenta una ferita aperta nella filiera italiana del lusso, sottolineando come anche marchi di grande prestigio non siano immuni dalla crisi produttiva e occupazionale.
Burberry e il licenziamento di 1.700 dipendenti: crisi nel lusso inglese
La crisi non risparmia neanche i colossi del lusso mondiale, come dimostra la situazione di Burberry a Londra. Il brand britannico ha annunciato il licenziamento di 1.700 dipendenti, una decisione drastica che riflette le difficoltà finanziarie e strategiche del gruppo. La riduzione del personale è accompagnata dalla cancellazione delle sfilate maschili previste per giugno 2025, un segnale evidente del ridimensionamento dell’attività promozionale e creativa.
Burberry ha registrato un calo del fatturato del 17%, con previsioni di perdite che potrebbero raggiungere i 90 milioni di euro nei prossimi due anni. Il nuovo CEO Joshua Schulman è chiamato a una difficile ristrutturazione che potrebbe ridefinire il futuro del brand, in un mercato globale del lusso sempre più competitivo e soggetto a continui shock.
Kering e Gucci: una rottura difficile da superare
Gucci, uno dei marchi di punta del gruppo francese Kering, attraversa una fase complessa segnata da un significativo calo delle vendite e da un cambio traumatico alla direzione creativa. L’uscita di Alessandro Michele, amatissimo dal pubblico e considerato un innovatore, ha lasciato un vuoto difficile da colmare.
Il successore Sabato de Sarno non è riuscito a invertire la tendenza negativa, anzi l’arrivo di Demna ha creato nuove divisioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Questo cambio di strategia ha portato a un calo delle vendite del 25%, un risultato che mette in discussione le scelte aziendali e la capacità di Kering di mantenere stabile uno dei suoi asset più preziosi.
La situazione sottolinea come il rapporto tra creatività e gestione finanziaria sia un equilibrio delicato e fragile, soprattutto in un settore così esigente e dinamico.
LVMH e la sfida dei dazi di Trump
Il colosso LVMH, guidato da Bernard Arnault, affronta una doppia sfida: da una parte la pressione dei dazi imposti dagli Stati Uniti, dall’altra il calo del valore delle azioni e del patrimonio personale del CEO. La guerra commerciale innescata dall’amministrazione Trump ha impattato negativamente sulle esportazioni e sugli investimenti, mettendo in difficoltà i marchi del gruppo come Louis Vuitton, che resta il brand di punta.
Il patrimonio di Arnault è diminuito di 9 miliardi di dollari, e la quotazione delle azioni LVMH mostra un andamento altalenante, riflettendo l’incertezza del mercato globale del lusso. Nonostante ciò, LVMH continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore, ma la situazione evidenzia la vulnerabilità anche delle aziende più solide di fronte a fattori esterni imprevedibili.
Il gruppo Prada acquisisce Versace: una buona notizia per la moda italiana
In questo contesto di difficoltà globali, l’acquisizione di Versace da parte del gruppo Prada rappresenta una delle poche notizie positive per la moda italiana. Questa operazione rafforza la leadership di Prada nel settore del lusso made in Italy, un comparto che da sempre ha rappresentato un fiore all’occhiello dell’industria nazionale. Donatella Versace e Miuccia Prada sono due figure chiave che incarnano lo spirito innovativo e la tradizione artigianale italiana. Nonostante le incertezze del mercato, Prada ha registrato una crescita a doppia cifra (+13%) nei primi tre mesi del 2025, raggiungendo ricavi netti di 1,341 miliardi di euro. Questa sinergia potrà contribuire a consolidare la presenza globale del lusso italiano, offrendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione.
Scognamiglio e Chiara Ferragni: ritorno al controllo dei brand
Un’altra tendenza significativa riguarda il ritorno al controllo diretto dei brand da parte dei loro fondatori o creativi. Francesco Scognamiglio, ad esempio, ha riacquistato il 100% della proprietà del suo marchio, aprendo la strada a un nuovo progetto che punta a unire moda, arte e identità personale. Allo stesso modo, Chiara Ferragni ha annunciato di detenere il 99% del suo brand, mantenendo così il controllo anche in un momento difficile per la sua società Fenice Srl. Questi ritorni alle origini rappresentano una risposta strategica alla crisi, sottolineando l’importanza di mantenere una visione coerente e personale nella gestione dei marchi, specialmente in un mercato complesso e in rapido cambiamento come quello attuale.
Gruppo Aeffe: Moschino e Alberta Ferretti in difficoltà
Il primo trimestre del 2025 è stato particolarmente sfidante per il gruppo Aeffe, che include marchi prestigiosi come Moschino e Alberta Ferretti. Nonostante il rinnovamento delle direzioni creative, i risultati economici non hanno rispettato le aspettative, con una perdita netta che è passata da 5,6 a 10,1 milioni di euro. Il fatturato retail ha subito un calo drastico, soprattutto sul mercato italiano (-24,7%), evidenziando la fragilità del settore anche in presenza di nomi storici e consolidati. Questa situazione mette in luce come, oltre alle scelte creative, anche la gestione commerciale e la capacità di adattamento alle nuove tendenze di consumo siano fondamentali per la sopravvivenza e la crescita nel mercato globale.
Lanvin Group e la crisi del gruppo cinese
Il gruppo Lanvin, proprietario di marchi storici come Sergio Rossi, sta vivendo una crisi profonda che potrebbe portare alla vendita totale dei suoi brand. Lanvin, la maison francese più antica di Parigi, simbolo di eleganza e tradizione, è oggi in bilico a causa delle difficoltà finanziarie e gestionali del gruppo cinese proprietario. L’uscita di Bruno Sialelli ha aperto una fase di transizione sotto la direzione creativa di Peter Copping, ma il futuro resta incerto. Questa crisi riflette le difficoltà del lusso tradizionale di mantenere la propria identità e competitività in un mercato sempre più globale e frammentato, dove innovazione e capacità di risposta ai cambiamenti sono cruciali.
Lusso e fast fashion: prezzi in aumento e nuove tendenze di consumo
Il mercato della moda sta vivendo una profonda trasformazione nelle abitudini di consumo. Da un lato, il lusso continua ad aumentare i prezzi, giustificando questa scelta con i costi crescenti di produzione, dazi e inflazione. Tuttavia, questo fenomeno spinge molti consumatori a spostarsi verso il mercato medio, il fast fashion e soprattutto il settore del second hand. Marchi come COS di H&M e Zara dominano le classifiche di vendita, grazie alla capacità di offrire prodotti alla moda a prezzi accessibili. Parallelamente, il mercato del second hand cresce in modo esponenziale, con piattaforme come Vinted che diventano leader nel settore, confermando un cambiamento radicale nelle modalità di acquisto, orientate sempre più alla sostenibilità e alla circolarità dei prodotti.
Il lusso di qualità resiste: Hermès, Zegna e Cucinelli
In un contesto di crisi e turbolenze globali, alcuni protagonisti del lusso di alta gamma dimostrano una resilienza notevole, consolidando la loro posizione e confermando l’importanza della qualità e dell’artigianalità. Hermès, ad esempio, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un incremento dei ricavi del 9%, confermando le stime positive per l’intero anno. Il brand francese ha inoltre annunciato l’apertura di una nuova fabbrica di pelletteria a Colombelles, in Normandia, con la creazione prevista di 260 posti di lavoro dedicati a artigiani altamente specializzati, un segnale chiaro di investimento nella tradizione e nel talento.
Anche Ermenegildo Zegna presenta risultati solidi, con ricavi per il primo trimestre a 458,8 milioni di euro, in lieve calo dell’1% su base annua ma con una crescita significativa dei suoi marchi Zegna, Tom Ford Fashion e Thom Browne, grazie anche al potenziamento del canale direct-to-consumer, vero motore di crescita con aumenti tra il 4% e il 10% anno su anno.
Brunello Cucinelli, infine, continua a sorprendere positivamente, registrando una crescita del 10% nei ricavi del primo trimestre 2025, in linea con le previsioni degli analisti, e confermando un andamento solido e sostenibile per tutto l’anno.
Questi esempi testimoniano che nell’olimpo del lusso la qualità, il valore e l’identità restano le chiavi per superare le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo. Il lusso vero non si misura solo dal prezzo, ma dalla capacità di raccontare storie autentiche e creare esperienze esclusive.
Ripensare la moda: resilienza e nuovi modelli di consumo
La crisi attuale impone una riflessione profonda e un cambiamento radicale nel modo di concepire e produrre la moda. Il modello tradizionale basato sulla sovrapproduzione non è più sostenibile né dal punto di vista economico né ambientale. Diventa fondamentale adottare strategie di upcycling, riciclo, second hand e vintage per ridurre l’impatto e valorizzare ciò che già esiste.
La moda, terzo settore manifatturiero italiano, deve rimettere al centro la persona, tutelando le competenze artigianali e promuovendo un’economia circolare. Questo approccio può rappresentare la chiave per una rinascita più solida e sostenibile, capace di affrontare le sfide del futuro con maggiore resilienza.
Oltre la crisi: un’industria da ripensare
Non servono più trend, ma nuovi valori
La crisi della moda non è solo economica, ma anche valoriale. Serve un cambiamento strutturale. L’industria è chiamata a ripensare il concetto stesso di consumo, spostandosi verso modelli rigenerativi: upcycling, second hand, vintage, produzione responsabile.
Come ha detto Brunello Cucinelli:
“Ai giovani chiedo di essere attori di una rivoluzione umanistica verso un Tempus Novum.”
La moda non ha bisogno solo di nuove collezioni, ma di nuovi significati.