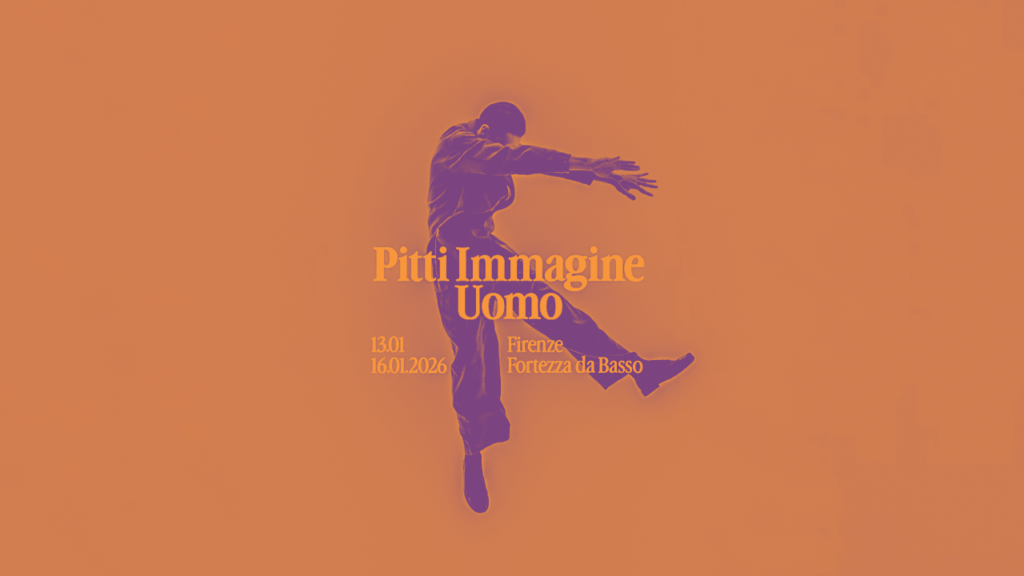Il tempio dell’amore e la liturgia del declino
Rick Owens ha presentato la collezione SS26 durante la Paris Fashion Week di giugno 2025, scegliendo ancora una volta il Palais de Tokyo come scenario per un’esperienza che travalica la semplice sfilata. Intitolata Temple, la collezione è un’estensione narrativa e performativa della retrospettiva Temple of Love che ha aperto poche ore dopo al Palais Galliera. Il risultato è una doppia operazione: da una parte, la messa in scena di una liturgia visiva e simbolica; dall’altra, l’autoanalisi di un percorso creativo che guarda tanto indietro quanto in avanti.
Scenografia e atmosfera: un tempio post-industriale
La struttura temporanea costruita all’interno della vasca centrale del Palais de Tokyo richiama un tempio azteco deformato, un monumento brutalista fatto di impalcature metalliche. Il pubblico, costretto a stare in piedi ai margini della fontana, assiste a una discesa rituale: i modelli emergono dall’alto e scendono attraverso scalinate precarie, attraversando l’acqua e in alcuni casi immergendosi completamente.
L’utilizzo dello spazio è coreografico: il percorso non è lineare, la camminata diventa performance, con momenti di stasi, immersione, tensione e rilascio. Fumo artificiale e luci fredde contribuiscono a un clima sacrale e disturbante, amplificato dalla colonna sonora – una rielaborazione elettronica e tragica del Dido’s Lament, reinterpretato da Klaus Nomi – che sottolinea il tono elegiaco della presentazione.
I capi: destrutturazione, rituale e tensione
La collezione SS26 si muove lungo due direttrici complementari: da un lato, il consolidamento di codici già noti nel vocabolario estetico di Owens – decostruzione, stratificazione, sensualità architettonica; dall’altro, l’inserimento di elementi simbolici e narrativi che evocano un’estetica da cerimonia decadente.
Capispalla e costruzione
Il cuore strutturale della collezione è costituito da una serie di giubbotti in cuoio nero veg-tanned, lavorato a Santa Croce sull’Arno. La pelle è spessa, opaca, materica, trattata con incisioni e tagli profondi che creano aperture e fenditure da cui affiora la pelle nuda dei modelli. I volumi sono ipertrofici: spalle esasperate, busti compatti, silhouette che comprimono il corpo come se fossero contenitori rituali.
I flight jacket, rivisitati in taffetà di seta e nylon tecnico industriale prodotto a Como, sono imbottiti e sovradimensionati. Gli orli si allungano in pieghe fluttuanti, mentre le zip metalliche, volutamente esposte, accentuano il contrasto tra leggerezza del tessuto e severità dell’impianto formale.
Dettagli e decorazioni
Un elemento ricorrente è l’utilizzo delle cinghie: non funzionali, ma disposte come ornamenti cerimoniali. Drappeggiate intorno al busto e agli arti, evocano ghirlande votive o strumenti di contenimento, in un gioco di tensioni tra costrizione e abbellimento. Le borchie sono presenti ma non aggressive; assumono un ruolo decorativo sottile, come piccoli punti di luce in una composizione altrimenti tenebrosa.
La pelle è usata anche come tessuto scultoreo, cucita in moduli sovrapposti, frangiata, o piegata in geometrie complesse. Alcuni pezzi sembrano derivare da un’antica armatura reinterpretata con tecniche sartoriali contemporanee. Altri, come le mantelle e i gilet oversize, sono privati di ogni funzionalità pratica e si avvicinano a oggetti votivi o costumi rituali.
Pantaloni, shorts e calzature
I pantaloni si alternano tra volumi compressi e silhouette over. Alcuni modelli in canvas grezzo presentano tagli netti e finiture a vivo, altri sono trattati con lavaggi chimici che creano effetti marmorizzati. Gli shorts, larghi e destrutturati, sono spesso accompagnati da sottostrati in tulle tecnico o jersey stretch, che introducono trasparenze ibride tra intimo e armatura.
Le calzature sono tra gli elementi più identificativi: i cosiddetti burrito sneaks, sandali ortopedici con chiusure a strappo, sono volutamente sproporzionati, con suole in gomma espansa e fascioni oversize in pelle o neoprene. Il risultato è una silhouette informe e totemica, a metà tra scultura biomeccanica e calzatura terapeutica.
Palette cromatica e materiali
La palette è limitata ma estremamente coerente: nero, grigio ferro, marrone cuoio, bianco osseo e una punta di verde oliva opaco. Il colore non è mai protagonista; è piuttosto il supporto emotivo della materia. Ogni tessuto è scelto per la sua consistenza e il suo comportamento cinetico. Il contrasto tra opaco e lucido, tra rigido e fluido, è il vero protagonista visivo.
I materiali sono prevalentemente naturali ma trattati in chiave industriale. Il cuoio, il canvas e la seta vengono manipolati per apparire usurati, vissuti, “sacralizzati” dal tempo. Alcuni capi sono realizzati in filati di maglieria prodotti in edizione limitata, riedizione di pezzi storici risalenti ai primi anni Duemila. La collaborazione con Terry-Ann Frencken – ex modella e knitwear designer – sottolinea la volontà di Rick Owens di riconnettersi con le sue origini creative.
Owens oltre il culto
La collezione SS26 non segna una frattura nel percorso estetico di Rick Owens, ma ne affina la grammatica, consolidando un lessico che da oltre due decenni definisce un’estetica riconoscibile e inimitabile. È un lavoro di cesello su codici ormai ritualizzati: un gesto consapevole di autoanalisi e affermazione, che si intreccia con la mostra retrospettiva Temple of Love, non come semplice archivio, ma come dispositivo vivo, attivo, politico.
Il linguaggio teatrale si estremizza, ma non si svuota. Ogni scelta – strutturale, materica, performativa – ha una funzione narrativa e simbolica. Nulla è decorativo, tutto è carico di significato. Lo show non è uno spettacolo: è un rito. La scenografia, i suoni, la gestualità, il ritmo, sono strumenti di evocazione, non di intrattenimento.
Con Temple, Owens non cerca approvazione. Non insegue le tendenze, né propone soluzioni indossabili nel senso convenzionale del termine. La sua moda è, da sempre, un linguaggio per comunicare tensioni interiori, riflessioni esistenziali, visioni estetiche radicali. Non è un prodotto, ma un medium.
In questa stagione, il messaggio è un atto d’amore: duro, verticale, intransigente. Un amore per il corpo come luogo di espressione e vulnerabilità, per la bellezza come costruzione mentale, e per l’abbigliamento come forma d’arte e pratica di resistenza. Fuori dal contesto rituale della sfilata, i suoi capi sembrerebbero reliquie mute. È nella messa in scena che si attivano, che vibrano, che vivono. Ed è lì che Rick Owens riafferma il suo ruolo: non stilista, ma officiatore di un culto contemporaneo che continua a rigenerarsi, stagione dopo stagione.