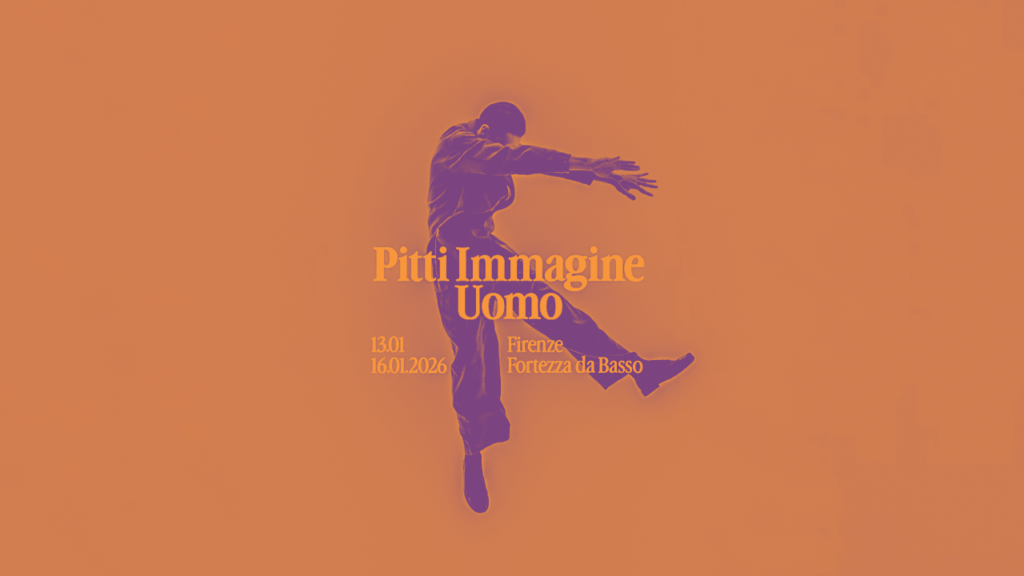Il caso Max Mara: insegnamenti e riflessioni
La filiera del Made in Italy è in piena rivoluzione. Un cambiamento che non nasce ieri, ma è frutto di una lenta evoluzione, accelerata oggi da due forze convergenti: la crisi che ha colpito il mercato globale del lusso e l’instabilità geopolitica ed economica mondiale. Se da una parte il made in Italy è ancora sinonimo di bellezza, eccellenza e saper fare, dall’altra è evidente che siamo davanti a una fase di vulnerabilità profonda. E il caso Max Mara, nelle ultime settimane, lo ha reso impossibile da ignorare.
Conosciamo tutti, almeno per sentito dire, i contorni di quella che viene spesso chiamata la “filiera made in italy”. Ma pochi ne comprendono le crepe strutturali. I suoi problemi non riguardano gli ultimi anni: sono decenni di politiche inefficienti, di mancati investimenti pubblici e di una narrazione retorica, spesso slegata dalla realtà dei territori.
L’Italia che produce, che cuce e assembla, che immagina e crea, è fatta di imprese familiari. Di storie tramandate tra generazioni. Di laboratori che resistono. È una frammentazione che può sembrare una debolezza ma è, al contrario, la nostra più autentica ricchezza. Perché è proprio nella pluralità di voci, tecniche e sensibilità che l’Italia riesce a fare sintesi e raccontarsi al mondo.
Filiera Made in Italy: il caso Max Mara
In questo contesto si inserisce una delle vicende più controverse e simboliche del 2025: quella che ha visto Max Mara al centro di una vera e propria tempesta mediatica, sociale e politica. Da un lato, l’immagine iconica del brand che compie 75 anni e celebra con una sfilata da sogno alla Reggia di Caserta. Dall’altro, le denunce delle sarte della Manifattura San Maurizio a Reggio Emilia, che parlano di condizioni di lavoro umilianti, ritmi insostenibili e salari troppo bassi per una vita dignitosa.
Mentre Gwyneth Paltrow balla la conga e Sharon Stone sorride ai flash, le lavoratrici – le vere mani dietro quei cappotti da sogno – raccontano una realtà ben diversa. Parole come “mucche da mungere” o “obese”, condizioni simili al cottimo per 1.300 euro al mese, e una dignità calpestata. Il tutto mentre il brand fattura 1,8 miliardi di euro.
La risposta dell’azienda è arrivata tramite Maria Giulia Prezioso Maramotti, membro del board e terza generazione della famiglia: «Non ci riconosciamo nelle affermazioni fatte». Ma il governo ha confermato che l’Ispettorato del lavoro ha riscontrato irregolarità e che sono in corso procedimenti interni. Il viceministro Maria Teresa Bellucci ha parlato di un «clima di sfiducia che necessita di un intervento correttivo».
A livello locale, la situazione è esplosiva. Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha bocciato un ordine del giorno di solidarietà alle lavoratrici. E mentre la politica si divide, Max Mara ritira il progetto più ambizioso degli ultimi anni: il Polo della Moda da costruire proprio a Reggio, nell’area delle ex Fiere. Un centro direzionale da 900 lavoratori che avrebbe ridisegnato la mappa economica e urbanistica della città. Un’occasione persa? Forse. Ma anche un campanello d’allarme.
Il Polo del Lusso che non sarà
Nato a Reggio Emilia nel 1951, Max Mara è stato uno dei pionieri del prêt-à-porter italiano. E proprio qui voleva tornare, investendo nel futuro. Ma un clima “divisivo”, come scritto nella lettera del presidente Luigi Maramotti al sindaco, ha portato al dietrofront. Troppe polemiche, troppa esposizione, troppa attenzione.
È un caso emblematico. Perché ci costringe a interrogarci non solo sul comportamento di un grande brand, ma anche sul ruolo delle istituzioni, dei sindacati, della stampa e dei cittadini. È un test sulla maturità di un intero sistema.
Luci e ombre del Made in Italy: dopo Max Mara, anche Loro Piana sotto la lente
A pochi giorni dal caso che ha coinvolto Max Mara, un altro gigante del lusso italiano finisce sotto i riflettori della giustizia. Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, brand simbolo dell’eccellenza tessile italiana e parte del gruppo LVMH, con Antoine Arnault alla presidenza del CdA.
L’indagine, condotta dal PM Paolo Storari, ha rivelato come l’azienda abbia affidato parte della produzione – tra cui giacche e capi d’abbigliamento – a terzi, in contesti dove sarebbero state accertate condizioni di grave sfruttamento del lavoro. Un duro colpo per l’immagine della filiera del Made in Italy, che solleva interrogativi urgenti sulla tracciabilità, l’etica produttiva e la responsabilità delle grandi maison nella tutela dei diritti dei lavoratori.
Ripensare la filiera del made in italy: Umanesimo Industriale
Cosa ci insegna tutto questo? Che il Made in Italy non si può più permettere di vivere di retorica. Che serve un piano serio, concreto, coraggioso. Servono politiche di sostegno che creino un ecosistema favorevole e non predatorio. Serve un nuovo patto tra pubblico e privato, dove il profitto non sia l’unico orizzonte possibile.
È necessario promuovere davvero le imprese che fanno grande il nome dei brand: gli artigiani, i laboratori, le sarte, i tecnici. Senza di loro, nessun cappotto potrebbe sfilare a Caserta. È urgente riscoprire un umanesimo industriale, in cui il lavoratore sia al centro della visione aziendale.
La sfida più grande? Il passaggio generazionale e la formazione continua. Non possiamo lasciare che un patrimonio così prezioso si dissolva. È tempo di guardare al futuro con realismo e immaginazione, costruendo scenari alternativi, dinamici, adattabili.
Perché se il Made in Italy vuole restare tale, deve tornare ad ascoltare le sue radici. Quelle che cucivano a mano, in silenzio. Quelle che oggi – finalmente – chiedono voce.