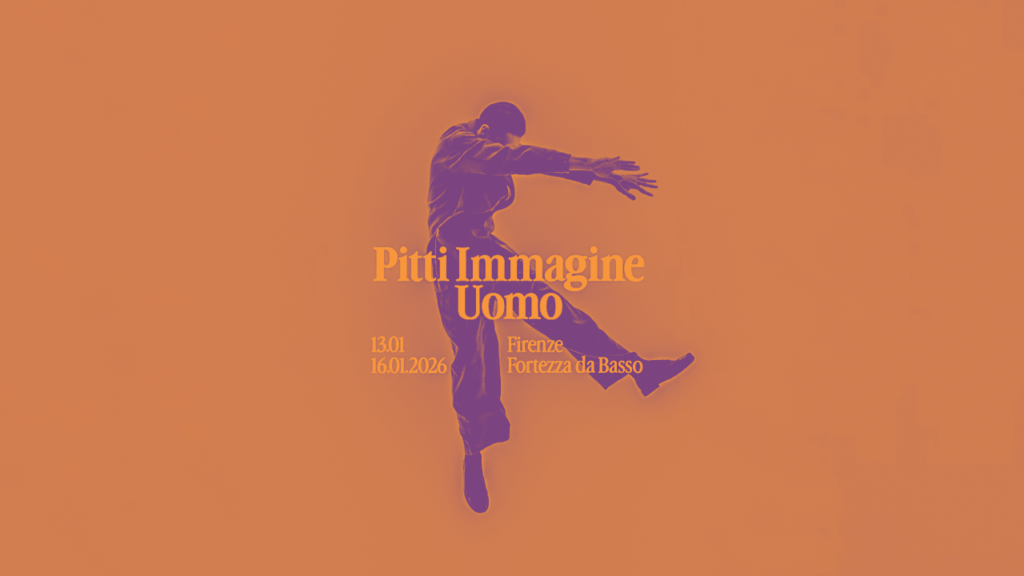Dal caso Armani ai destini del Made in Italy tra famiglie, capitali e globalizzazione
L’Italia delle imprese è un mosaico affascinante e fragile, fatto di realtà familiari, di storie personali che diventano marchi globali, e di un equilibrio costante tra tradizione e innovazione. In questi giorni, il testamento di Giorgio Armani ha riportato con forza al centro del dibattito una questione che va ben oltre la moda: il futuro delle aziende italiane e del capitalismo nazionale.
Il clamore non è nato tanto dalla ripartizione dell’eredità tra i familiari, quanto dalle disposizioni economiche che lo stilista ha voluto mettere nero su bianco. Nel documento si legge infatti la volontà di aprire una parte del capitale a potenziali colossi internazionali come LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica. Una prospettiva che per molti suona come una frattura rispetto all’immagine di un marchio simbolo di indipendenza e solidità, cresciuto in decenni di lavoro e disciplina.
Secondo quanto trapelato, il 15% del gruppo potrebbe passare nelle mani di un grande player straniero, aprendo scenari del tutto nuovi non solo per Armani, ma per l’intero comparto del Made in Italy. Una decisione che si intreccia con il tema del golden power, lo strumento di tutela annunciato dal governo per vigilare sugli asset strategici italiani, ma che allo stesso tempo porta alla luce un problema più ampio: la capacità del nostro sistema industriale di crescere senza snaturarsi.
Il modello familiare: forza e limite del capitalismo italiano
In Italia, l’impresa è spesso sinonimo di famiglia. Dalla moda al cibo, dal design alla meccanica di precisione, la spina dorsale del nostro tessuto produttivo è costituita da aziende a conduzione familiare. Questo modello ha generato eccellenze e marchi iconici, creando una pluralità che rende unico il panorama industriale nazionale.
Tuttavia, in un mercato globale dominato da colossi multinazionali, la frammentazione può trasformarsi in debolezza. Le imprese italiane, pur eccellenti nella creatività e nella qualità, spesso faticano a raggiungere le dimensioni necessarie per competere su scala internazionale.
Proprio qui entra in gioco il dilemma affrontato con lucidità da Giorgio Armani.
Continuare a crescere in totale indipendenza o aprirsi a partnership e investimenti esterni per garantire un futuro più solido e competitivo?
La scelta non riguarda solo un’azienda, ma riflette una sfida comune a molte realtà italiane.
Dal “piccolo è bello” alle economie di scala
Negli anni ’80, lo slogan “piccolo è bello” era considerato un punto di forza. Rappresentava flessibilità, artigianalità e radicamento sul territorio. Oggi, però, il paradigma è cambiato.
Come ricordava Sergio Marchionne parlando dell’automotive, senza aggregazioni e economie di scala, la competitività è a rischio. Lo stesso vale per la moda, un settore in cui i grandi gruppi internazionali – da Kering a LVMH – hanno costruito imperi proprio grazie a fusioni e acquisizioni.
Il caso Armani non è quindi un episodio isolato. È il simbolo di un bivio che molte aziende italiane si trovano davanti: restare fedeli a un modello familiare che tutela il controllo ma limita la crescita, oppure aprirsi al mercato dei capitali e abbracciare un nuovo equilibrio di governance.
Esempi virtuosi e scenari possibili
Non mancano esempi positivi. Ferrero ha dimostrato che si può rimanere indipendenti, pur senza la quotazione in Borsa, crescendo fino a diventare un colosso mondiale da oltre 14 miliardi di fatturato, tra Nutella, Kinder e acquisizioni mirate come quella di Thorntons nel Regno Unito e delle attività dolciarie della Nestlé negli Stati Uniti.
Luxottica, invece, ha scelto la via dell’ibridazione: la fusione con Essilor ha dato vita a EssilorLuxottica, un gigante internazionale con una governance condivisa, ma che mantiene nel DNA il genio imprenditoriale di Leonardo Del Vecchio e la sua anima profondamente italiana.
C’è poi il caso di Moncler, che ha imboccato la strada della quotazione a Piazza Affari nel 2013. L’operazione non ha snaturato il marchio, ma lo ha reso ancora più competitivo, permettendo acquisizioni come Stone Island e posizionandolo tra i player globali più dinamici della moda di lusso.
All’opposto, molti brand storici del Made in Italy hanno imboccato percorsi diversi, spesso dettati dalla necessità più che dalla strategia. Gucci, emblema della moda fiorentina, è oggi parte del gruppo francese Kering. Fendi e Bulgari sono entrati nell’universo LVMH. Valentino, a lungo controllata dal fondo sovrano del Qatar, è ora in parte nelle mani di Kering. Sono acquisizioni che hanno garantito solidità finanziaria e visibilità internazionale, ma che hanno segnato la perdita di controllo da parte italiana.
Un altro esempio virtuoso arriva dall’alimentare. Illycaffè ha aperto parte del capitale a un fondo di investimento come Rhône Capital, mantenendo la guida familiare ma rafforzando la struttura finanziaria per affrontare la sfida dei mercati globali. Lo stesso percorso, con modalità diverse, è stato intrapreso da Sammontana, che ha avviato il processo di quotazione per crescere senza rinunciare all’identità.
Il quadro è quindi sfaccettato: ci sono storie di successo nella piena indipendenza, percorsi di apertura al mercato che hanno rafforzato i brand, ma anche casi in cui l’incapacità o la reticenza ad evolvere ha portato alla cessione a colossi stranieri.
La lezione comune è chiara: in un mondo che accelera, l’epoca dell’autarchia industriale è ormai un capitolo chiuso.
Il futuro del Made in Italy
Il punto centrale non riguarda tanto la vendita di quote o la quotazione in Borsa. Ciò che conta davvero è la capacità di ripensare il modello di impresa italiana. Aprirsi a investitori esteri o istituzionali non significa tradire la propria identità. Al contrario, può rafforzarla, fornendo strumenti finanziari e manageriali indispensabili per competere in un mercato sempre più globale.
Il testamento di Giorgio Armani, con la sua visione pragmatica e lucida, va oltre la dimensione privata. Si trasforma in un vero e proprio messaggio politico e industriale. È un invito a superare l’idea che l’autosufficienza familiare sia l’unica via possibile. Talvolta, condividere la guida e aprirsi a nuove forme di governance può tradursi in maggiore solidità, crescita e capacità di affrontare le sfide del futuro.